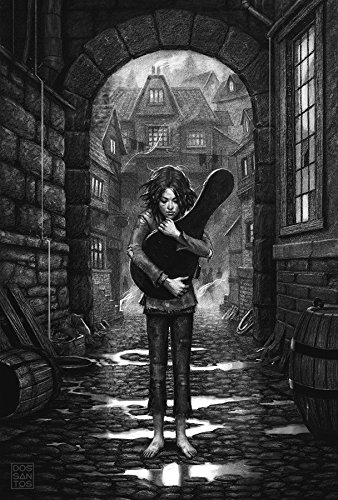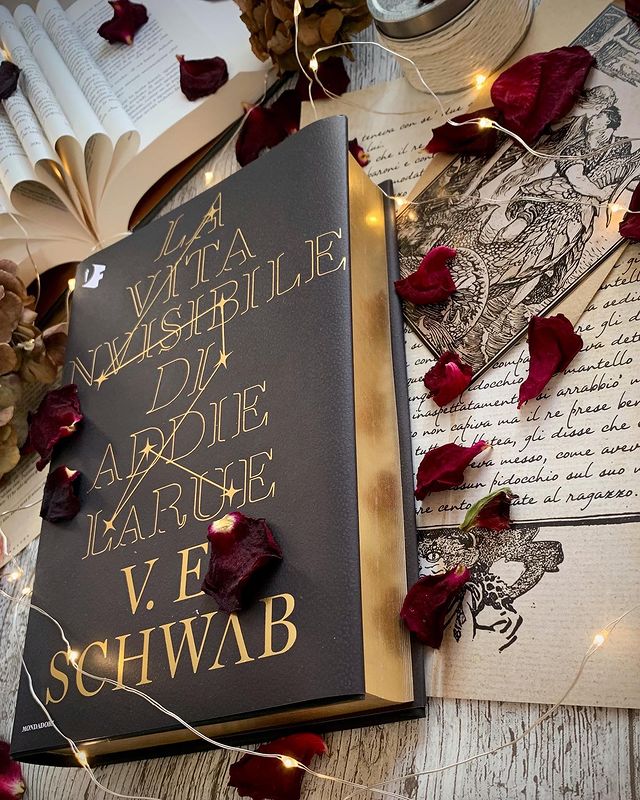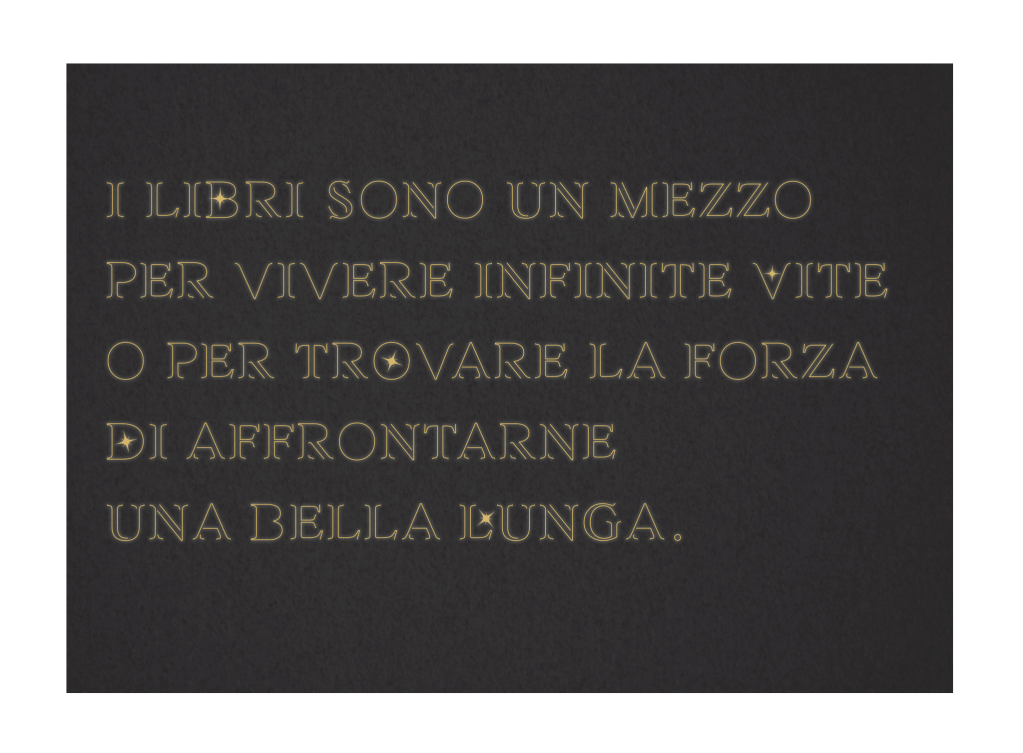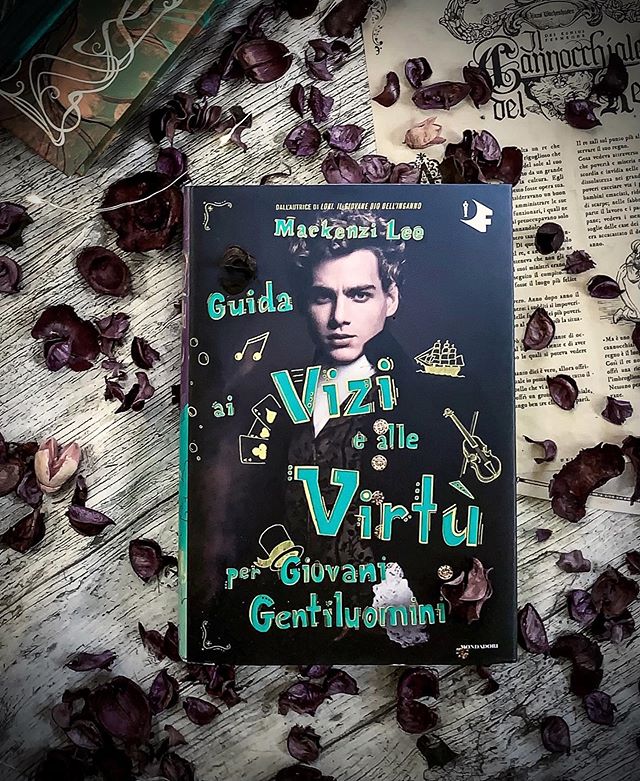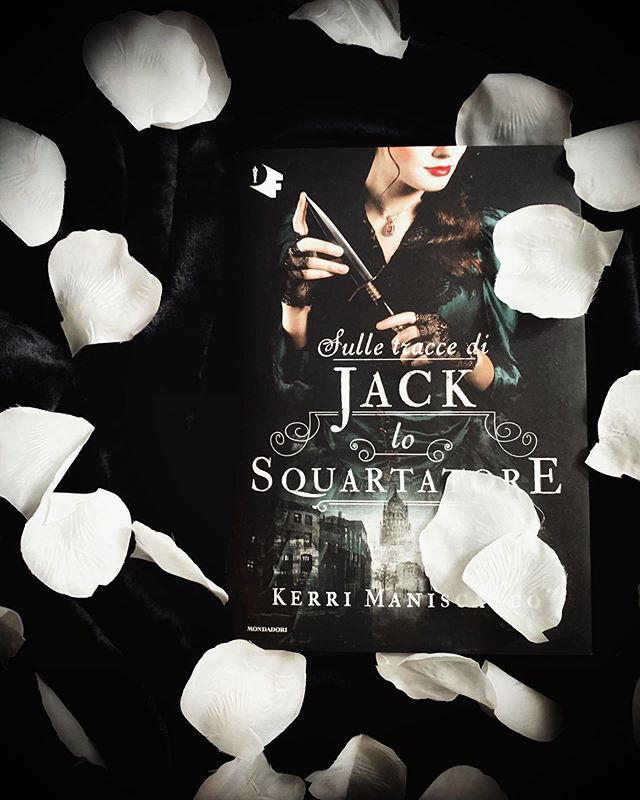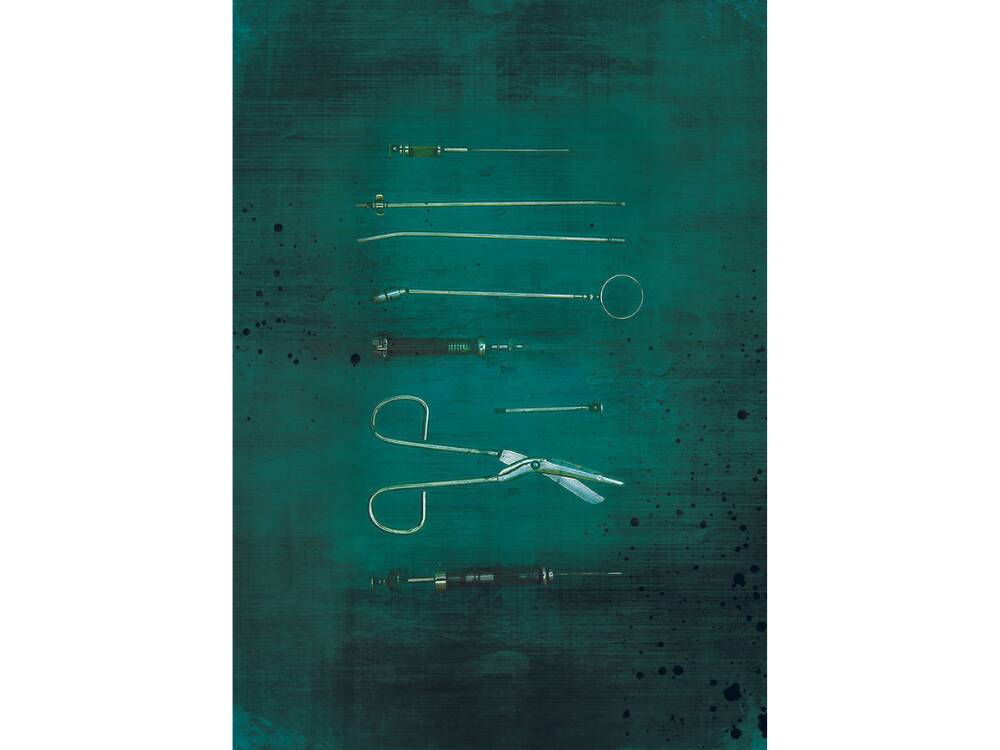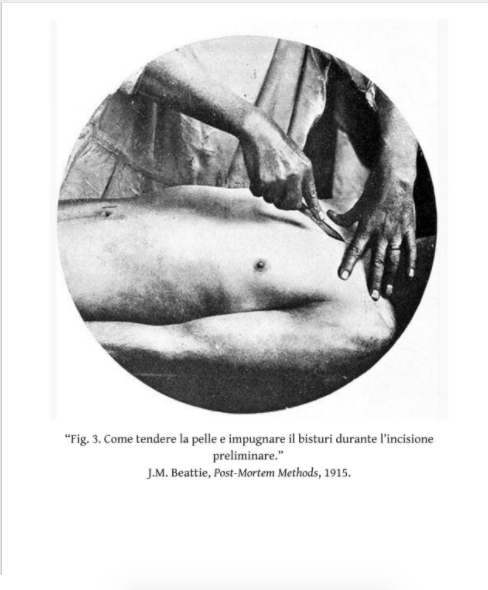Buondì lettori, oggi ho il piacere di parlarvi di Colorful – Il giorno che sono diventato te della scrittrice giapponese Eto Mori, primo romanzo della serie DeAWave della DeAgostini, dedicata agli amanti della letteratura asiatica. Prima di iniziare a parlarvi del libro, ci tengo a ringraziare Yelena de La libreria di Yely per avermi coinvolta nel review party e la DeAgostini per l’opportunità e la copia.
La trama: Essere morti ha i suoi svantaggi: niente pomeriggi insieme agli amici, niente ramen, niente tramonti da ammirare abbracciati alla persona che si ama. Insomma, niente di niente. Si è solo un’anima senza corpo, in attesa della reincarnazione. A meno che… A meno che tu non abbia commesso un tremendo errore nella vita precedente. In tal caso, è tutta un’altra storia. Per te, il circolo delle rinascite è off limits, c’è solo il grande e oscuro vuoto. A volte, però, il Grande Capo ha voglia di giocare e indice la Prestigiosa Lotteria delle Anime. Perché non dare una seconda possibilità a quei disgraziati? dice lui. Al vincitore della lotteria viene concessa la possibilità di tornare sulla Terra in un nuovo corpo e con una missione precisa: porre rimedio agli errori del passato prima che il tempo concesso scada. Nessuno vorrebbe sprecare la sua unica seconda possibilità, ma è più facile a dirsi che a farsi, ve lo assicuro. Lo sa bene l’anima vincitrice di questa tornata della lotteria, a cui è capitato in sorte il corpo – e soprattutto la famiglia – di Makoto Kobayashi, un timido quattordicenne che si è appena suicidato. L’anima non ha la più pallida idea di cosa fare, ma, forse, scoprire il motivo che ha spinto Makoto a togliersi la vita potrebbe aiutarla a scoprire qualcosa di più anche su se stessa…

“Se solo sotto questo letto ci fosse l’oceano, mi trovo a pensare. Se solo potessi continuare a sprofondare così, sempre più giù, per sempre…“
Dopo aver vinto la lotteria delle anime, l’anima protagonista si reincarna nel corpo di Makoto. Guidata da Prapura, il suo angelo custode, l’anima dovrà cercare di non incasinare la vita del corpo che possiede, si ritroverà quindi a vivere con la famiglia del ragazzo, frequentare la sua scuola, compiendo così un viaggio di rinascita e di seconda possibilità della durata di nove mesi, nel mentre dovrà cercare di ricordare i peccati che ha commesso nella sua vita precedente. Se avrà successo, terminata la sua missione, l’anima potrà accedere al ciclo di reincarnazione, altrimenti verrà dispersa per l’eternità.
Non vi parlo ulteriormente della trama perché vista la brevità del romanzo sarebbe facile incorrere in spoiler, ma devo dirvi che è stata una lettura estremamente coinvolgente, tanto che ho finito il libro in un solo pomeriggio perché davvero non riuscivo a metterlo giù.
Parlare di questo libro non è affatto facile, nonostante le poche pagine (all’incirca 200), il breve ma coinvolgente viaggio dell’anima che si reincarna nel corpo di Makoto mi ha colpita in modo profondo e incredibile. Colorful è un libro di narrativa che è stato tradotto in tutto il mondo e trasposto in film e anime, una fama più che meritata, e sono convinta che, nonostante sia rivolto a un pubblico più giovane, è una lettura che andrebbe fatta a qualsiasi età.
Colorful è un bellissimo inno alla vita e ai suoi colori, un romanzo che parla di umanità e delle sue mille sfaccettature, che riesce a toccare in modo delicato, toccante, semplice e ironico temi difficili e complessi, come fragilità, salute mentale, bullismo, suicidio. Una storia che ci ricorda che c’è luce anche nei momenti più oscuri, che esistono seconde possibilità e che sta a noi cogliere la bellezza di ciò che ci circonda, riscoprendo con occhi nuovi la bellezza dei legami, degli affetti, delle cose che ci appassionano, accogliendo anche i difetti, gli errori, e accettando l’idea che nessuno è infallibile o perfetto, nemmeno le figure che idealizziamo sin dall’infanzia, come i genitori.
Colorful è stata una lettura emozionante, mi sono ritrovata più volte a commuovermi, sentendomi chiamata, in qualche modo in causa. Penso sia un libro che fa riflettere e che può aiutare se solo gliene diamo la possibilità. Tra le tante cose, mentre leggevo, mi sono ritrovata a pensare che ognuno di noi costudisce un universo dentro di sé e che quando entriamo in contatto con gli altri riusciamo solo a sfiorarne la superficie. Accedere a quell’infinito è difficile e complesso, è più facile fermarsi lì, guardare da lontano, giudicare, che fermarsi a comprendere, è difficile fermarsi ad ascoltare.
Come avrete capito, nonostante la semplicità della storia, Colorful è un romanzo che è riuscito a parlare alla mia anima, quindi non posso che consigliarlo a tutti e soprattuto a coloro che almeno una volta nella vita si sono sentiti persi, stanchi, sopraffatti, sbagliati.
Vi segnalo inoltre l’anime, con lo stesso titolo, che presto guarderò anch’io, uscito qualche anno fa e disponibile su Prime Video.

Vi lascio con un pò di citazioni tratte dal libro:
“Non ricordo nulla della mia vita. Però ho ancora addosso l’impressione che sia stata vagamente triste. E faticosa. E adesso che sono qui, qualsiasi cosa sia questo qui, non ho nessuna intenzione di arrampicarmi per tornare in cima a questo buco. Figuriamoci se ho voglia di tornare di là… dai vivi! Troppa fatica. E io sono stanco.”
“Forse chiunque su questa Terra vive la propria vita alimentato da false impressioni, fraintendendo gli altri e venendo a sua volta frainteso. é un’idea straziante, ma è anche vero che a volte le cose vanno bene proprio grazie a questo.”
“Siamo tutti così. Ognuno di noi ha la sua scatola di colori, alcuni sono belli e altri brutti.”
“Chiunque, in questo mondo terribile, ha le proprie crepe, le proprie ferite. Siamo tutti un pò rotti, in qualche modo.”